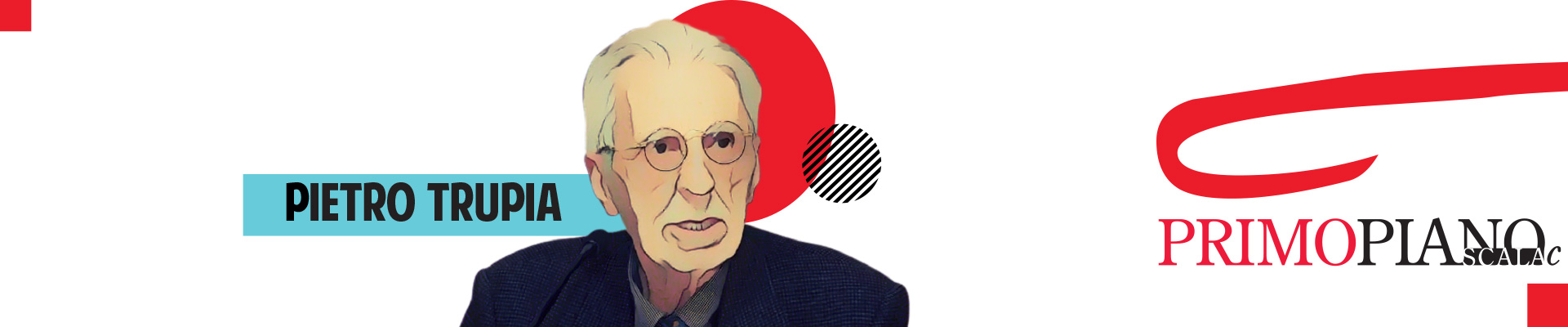
E intanto la Bellezza può salvare l’Italia
“Nella nostra lingua manca persino la parola per indicare lo specialista dell’arte. Artologo? Non suona.”
Telos: L’Italia possiede il più grande patrimonio artistico mondiale. Se aggiungiamo il paesaggio, possiamo parlare del nostro Paese come del luogo mondiale della Bellezza. Quale consapevolezza, quali programmi, quale responsabilità per noi italiani?
Piero Trupia: La consapevolezza è quella della comprensione del valore di ciò che si possiede e del quale si è depositari. Ma sembra che manchi l’orgoglio di ciò che si ha in casa. La consapevolezza passa per la cultura e anche a questo riguardo non stiamo bene. I programmi sarebbero di conservazione prima, di valorizzazione dopo. La nostra responsabilità è enorme; superiore alle nostre forze: essere affidatari, custodi e valorizzatori dei nostri tesori per conto dell’umanità. Procediamo per gradi e parliamo della consapevolezza che è insufficiente. Manca la cultura specifica anche nelle classi scolarizzate e negli addetti ai lavori. La cultura artistica degli italiani è nella media mondiale. Ne è prova il trionfo anche da noi del kitsch o l’utilizzo di monumenti come location di spettacoli chiassosi e volgari. Nella scuola, musica e arte sono cenerentole. Cosa s’insegna sull’arte? Storia dell’arte, idem per la letteratura e la filosofia. Le tre grazie della cultura umanistica ingabbiate nella diacronia estrinseca del prima e del dopo, invece che nell’individuazione del valore di ogni evento in sé e per sé.
I critici parlano del contesto, dei rimandi e dei richiami di un’opera ad altre opere; sono afasici su ciò che l’opera ha da dirci e come. Cosa accadrebbe, se i medici fossero esperti di storia della medicina e non di medicina? Nella nostra lingua manca persino la parola per indicare lo specialista dell’arte. Artologo? Non suona.
Parliamo di programmi e responsabilità.
I programmi non esistono. Si vive sull’emergenza, in attesa del prossimo crollo. I cittadini s’indignano, protestano, accusano, assaporano l’amaro gusto del risentimento e fanno audience nei talk show. La responsabilità è enorme e inebriante. Anzitutto conservare, dopo però aver sacralizzato i luoghi della Bellezza. Al momento abbiamo due bancarelle addossate alla ringhiera di Fontana di Trevi e quella, unica finora, davanti al Pantheon, “opera più divina che umana” per Michelangelo. Sacra, per l’appunto. C’è poi la parte creativa: fare del nostro Paese un luogo dell’anima, dove passare almeno una settimana della propria vita. Come Taormina nell’Ottocento e la Costa Azzurra prima della vippizzazione. Un intervento altamente creativo sarebbe l’anastilosi: tirar su e ricomporre i frammenti dei monumenti antichi. Bisogna dire che la parola turismo non è più attuale; non è utile all’offerta e alla domanda di un’esperienza di arte. Tra Sette e Ottocento fu attiva in Inghilterra una Society of Dilettanti. Viaggio in Italia e importazione dell’opera lirica. Dilettanti appassionati e colti per i quali, come per tutti gli europei di livello, il Grand Tour, almeno un mese, era un’esperienza formativa e un’avventura dello spirito. Gli italiani tutti devono essere anfitrioni e ciceroni della nuova realtà del turismo. I casali, le masserie, le case private, i bagli, i cortili vanno aperti agli ospiti per condividere l’Italian way of life. Qualcosa già s’intravvede.
È un vasto programma, avrebbe detto il Generale De Gaulle. Come fare? Si prova smarrimento di fronte a una tale compito.
Il programma è vasto ma è a misura del tesoro da rendere disponibile e godibile al mondo intero. Tre condizioni preliminari. Una presa di coscienza del valore economico della nostra bellezza. E includo in essa l’intelligenza e lo spessore storico della nostra cultura. Sono i fattori che hanno dato vita nei secoli al paesaggio agrario. Il fatto che la Bellezza è un patrimonio, non un capitale. Metterlo a frutto, preservandone l’integrità. Infine, l’iniziativa dal basso nell’apprestare l’accoglienza, insieme a una vigilanza dall’alto, a evitare abusi e patacche. Abbiamo realizzato dal basso e coralmente il capolavoro del Made in Italy, che nel profondo significa aver inculturato il mondo in tre settori vitali: moda, arredamento, agroalimentare. Ne fanno parte anche l’automazione, la bioingegneria e i comparti dell’artigianato di qualità, come la liuteria e altri strumenti musicali. Non sono cose che s’improvvisano. Dietro ognuno di questi artigiani ci sono secoli di lavoro manuale e intellettuale. Consapevolezza equivale a conoscere l’Italia nel profondo, in ciò che la fa diversa e non in ciò che la omologa al resto del mondo. Pertanto, una conoscenza adeguata e appropriata dell’arte in tutte le sue manifestazioni, del suo significato e del suo significare, la semantica dei suoi linguaggi. Non va esclusa la storia naturalmente.
È bello ciò che piace o esiste un canone universale? E poi, la Bellezza può salvare il mondo?
A Curitiba, in Brasile, un ristoratore di origine italiana ha arredato la sua trattoria con copie in marmo di Carrara di alcuni capolavori della scultura italiana del Rinascimento, dal David di Michelangelo in giù. Un orrore. È bello ciò che piace? Tale questione ha una storia. All’origine una citazione errata da Tommaso D’Aquino: Pulcra, dicuntur, quae visa placent (si dice che sono belle le cose che piacciono). Il primo a citare omise il dicuntur e gli altri citanti citarono da lui. Ma la dottrina del Bello di Tommaso è altra cosa. Ad pulchritudinem tria requiruntur: integritas sive perfectio, concordantia sive consonantia, claritas (per la bellezza occorrono tre cose: integrità ovvero perfezione, concordanza ovvero consonanza, claritas). Claritas non è chiarezza. Joyce suggerì “La verità nel suo splendore”. Non quella descrittiva della scienza, non quella argomentativa della filosofia. È la verità assoluta che dall’iperuranio metafisico delle essenze scende in terra e risplende nelle cose comuni, quando, riconfigurate nel linguaggio dell’arte, testimoniano una storia carica di valore umano. Non sono le cose a essere belle, ma ciò di cui sono simbolo. Precisa Tommaso: pulchra quamvis turpia (belle anche se brutte). Una crocifissione di Grünewald, gli scarponi e i Mangiatori di patate di Van Gogh, le deformità di Picasso. Credo davvero che la Bellezza possa salvare il mondo. La Bellezza è pacifica; non è acquisitiva, tranne che per i maniaci del possesso e gli esibizionisti. Personalmente preferisco un capolavoro in un museo che non a casa mia. La Bellezza può salvare il mondo, in un vivere secondo la qualità e non secondo la quantità, secondo la fruizione e non l’appropriazione. La sua verità è suadente, non soggiogante. La lotta esasperata per il possesso è distruttiva. A conclusione della seconda guerra mondiale gli alleati, per stanare i tedeschi che non c’erano, distrussero l’abbazia di Montecassino. Un doppio sacrilegio. L’Italia che, secondo Costituzione, ripudia la guerra, è chiamata a diffondere la pace con l’accoglienza, con la convivialità, con la qualità della vita.
Editoriale
Alla domanda qual è il valore economico della bellezza oggi? tutti rispondono: elevatissimo! Ma si riferiscono alla cosmesi e alla chirurgia estetica. E giù a snocciolare cifre sulle spese per creme, interventi e botox. Solo in un secondo momento, quando l’equivoco è chiarito e la domanda riformulata, cambia la risposta. Quanto è importante la Bellezza per l’Italia? È presto detto: a parole tanto nei fatti poco, anzi pochissimo. E i motivi sono molti, come ci racconta Piero Trupia in questa intervista colta, pungente, piena di spunti pratici, e bella. Le suggestioni e i pensieri che Trupia ci propone si discostano anni luce dalla solita solfa dell’arte e della cultura come capitale nazionale, anzi asset. Domandando e ridomandando, fa capolino la parola negletta e quasi impronunciabile: “patrimonio”. Patrimonio, bene intangibile nella sua consistenza e nella sua forma. Non però mummificato. Vissuto con civiltà, ammirato, studiato per la testimonianza di una cultura che è ancora viva. Di questo patrimonio dobbiamo essere custodi e valorizzatori per un suo godimento senza manipolazioni o scempi volgari. Quindi non bancarelle addossate alla balaustra della fontana di Trevi o pavimentazione del Colosseo per riproporre finte - fortunatamente - battaglie di gladiatori. Bastano gli antichi romani di fuori, con calzari e calzini. Trupia c’invita a riflettere su chi siamo, da dove veniamo e dove potremmo andare. Non come sterile e vacuo esercizio di autocompiacimento o di eroica speranza, né per ricordare il bel tempo che fu e quello, ancora più bello, che verrà; bensì per riuscire a cogliere i nostri punti di forza, individuare le resistenze e le responsabilità e prendere coscienza del “valore economico della nostra bellezza”. Qualcosa di importante è stata già fatto ed è il Made in Italy che, in questi anni di crisi, ha continuato a esportare generando l’attivo della nostra bilancia commerciale. Nel mondo, quando si può, si arreda, ci si veste e si mangia italiano. Un risultato importante raggiunto senza nemmeno proporselo. Un secondo miracolo economico. Dobbiamo ora accogliere i molti che vogliono venire in Italia non solo per ammirare, ma anche per sperimentare la nostra qualità di vita. Questa è la chiave di lettura forte, chiara, condivisibile dell’intervista, per uscire dalle secche nelle quali da troppo tempo siamo insabbiati. Con questo numero di dicembre, dedicato alla Bellezza con la B maiuscola, tutti noi di Telos desideriamo augurarvi Buone Feste ed un 2015 pieno di un bel futuro.
Mariella Palazzolo

Linguista, cognitivista, filosofo del linguaggio. Studi di matematica, logica, epistemologia, economia. Ultimamente si è interessato alla comprensione dell’arte. Ha pubblicato Perché è bello ciò che è bello. La nuova semantica dell’arte figurativa (2012) e sta lavorando a un libro sulla narratologia. Tra le sue altre pubblicazioni: L’avvicendamento nell’impresa familiare. Una sfida per la formazione (2013), Semantica della comunicazione (2001), Potere di convocazione. Manuale per una comunicazione efficace (2003), con Mario Unnia Parlamento che farne. Una risposta politically incorrect (2006), Cento talleri di verità. Autobiografia didattica per eventi (2011). Ha insegnato alla Scuola di Management della Luiss di Roma (Comunicazione Politica). Distinguished Professor a La Jolla University of California - San Diego F.C. (Organizational Management). Ha insegnato all’Università di Firenze (Scrittura e Narrative literature), all’Università di Lugano (Comunicazione convocativa). Oratore coinvolgente dall’ironia irresistibile, formatore certificato AIF per meriti e fama. È stato dirigente industriale. Ama i gatti raccolti in strada che diventano signore e signori della casa. Cucina per sé e per gli amici, anche per allentare la tensione del lavoro intellettuale.